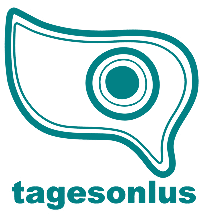Un approccio Orientale alla sofferenza psichica
A cura di: Mario Talvacchia Psicologo, Psicoterapeuta, studioso di Psicologie e Filosofie D’Oriente
È possibile che prendendo atto della propria sofferenza psichica sia possibile superare modelli comportamentali nevrotici e liberarsi da un senso negativo di sé profondamente radicato?
La sola consapevolezza è di per sé sufficiente? Quanto gli insegnamenti Orientali sulla sofferenza, sull’illusione e sul non attaccamento possono aiutare lo psicoterapeuta moderno a districarsi all’interno del mondo psichico del paziente aiutando lo stesso a riappropriarsi dei ricordi, ad elaborare emozioni dolorose e a dare una nuova direzione alle energie distruttive?
Questo articolo è il tentativo di riflettere su questi interrogativi…non certo di rispondere. Il grande psicologo americano William James rimase colpito dal livello di raffinatezza psicologica del pensiero buddista e predisse che questo avrebbe esercitato un grande ascendente sulla psicologia occidentale; dopo oltre cinquant’anni dalla sua profezia quest’influsso è sotto gli occhi di tutti. James comprese qualcosa che le successive generazioni, influenzate dalla psicoanalisi, non compresero: la dimensione psicologica fondamentale dell’esperienza spirituale buddista; “tutto ciò che si manifesta nella psiche deve essere fatto oggetto di consapevolezza.
È qui l’incontro con la psicoterapia; la consapevolezza e il rallentamento richiesto dalla stessa sono al servizio di un esame più approfondito della mente quotidiana. Si tratta di un lavoro sulla psiche, sul senso di vuoto e di falsità che spinge le persone a idealizzare o svalutare se stesse, fino alla costruzione di un senso d’identità confuso e alienato. Il merito della psicologia buddista è quello di aver riconosciuto la necessità di liberarsi dalle emozioni distruttive ma, cosa ancora più importante, al tempo stesso di come questa libertà venga da una consapevolezza di quelle stesse emozioni di cui cerchiamo di liberarci, una consapevolezza speciale in quanto “non giudicante”.
Molta sofferenza psichica origina dalla estenuante ricerca del piacere che per sua stessa natura è fugace, non può essere mantenuto all’infinito e il suo appagamento ci riporta ad uno stato di bisogno, di inquietudine, di desiderio e tensione. Spesso si è alla ricerca insaziabile di soddisfazioni impossibili, ossessionati dai nostri desideri fantasmatici con i quali bisogna venire a contatto. La condizione centrale del regno umano è che l’uomo non sa veramente chi è; lo psicoanalista D. Winnicot scriveva che “ogni individuo è isolato, costantemente ignoto, di fatto non scoperto”.
L’uomo avverte dunque un vago e inquietante senso di vuoto, di in autenticità, di alienazione..di insicurezza, ed è costretto a costruirsi quello che lo stesso Winnicot chiama un “falso sé” nel tentativo di sentirsi reale, per far fronte ad una situazione impossibile. Lungo il percorso psicoterapico il terapeuta dovrebbe accompagnare il paziente verso un lento e graduale apprendimento di un altro modo di entrare in relazione con questo falso se e con le emozioni di ogni dimensione; esiste dunque un modo di trasformare la sofferenza modificando il modo di entrare in contatto con essa, grazie alla comprensione che trasforma. La psicologia del buddismo riflette tanto sul quel profondo senso di “insoddisfazione totale” che pervade il nostro essere; tutti noi siamo rosi da un senso di imperfezione, di insostanzialità, di incertezza e di inquietudine, allo stesso tempo vorremmo che il disagio si risolvesse per incanto. La nostra identità non è mai così definita come pensiamo dovrebbe essere.
Come Narciso rischiamo di attaccarci a quest’immagine di completezza per alleviare il senso di irrealtà da noi avvertito, ma a Narciso quest’attaccamento all’immagine di perfezione costo la vita. Come primo passo potremmo familiarizzarci con questa identità fragile e insostanziale; nessuno vuole ammettere dinanzi a se stesso la propria insostanzialità, e allora si fa di tutto per proiettare un’immagine di completezza e di autosufficienza.
Winnicott diceva che tutti si impongono una coerenza per sopravvivere, ma non ci rendiamo conto che potrebbe essere proprio la rigidità di questo “falso sé” a far si che perduri il disagio e l’insoddisfazione. Questo “falso sé” che costruiamo ha due polarità; il sé grandioso che si sviluppa per compiacere alle richieste dei genitori e ha continuamente bisogno d’ammirazione, e il sé svalutato, solo e immiserito, alienato e insicuro, consapevole soltanto dell’amore che gli è stato negato. Il sé grandioso, seppur fragile e dipendente dall’ammirazione degli altri, si crede onnipotente o autosufficiente, e quindi si ritira nell’isolamento o nella distanza emotiva, il sé svalutato si aggrappa disperatamente a ciò che pensa possa alleviare la sua inconsistenza o si rifugia in un vuoto desolato dove rimane inavvicinabile, e che rinforza la sua convinzione di non valere niente.
Riassumendo potremmo dire che l’idea centrale parla di uno stato originario di perfezione, immaginario o reale, a cui la persona aspira ma che rimane irraggiungibile; la persone deve trovare il modo di tollerare il proprio innato senso di incertezza. La psicologia buddista postula un’insicurezza esistenziale di fondo e invita, paradossalmente, a non aggrapparsi con forza ad immagini rigidamente costruite, ma a coltivare il “dubbio”; non ci sarebbe bisogno di un’identità così forte e rigida per sopravvivere. I dubbi sul sé sono inevitabili e si presentano via via lungo il processo di maturazione; invece di soffocarli potremmo provare ad esplorarli, entrando nel dubbio anziché fuggirlo, accettare le incertezze che altrimenti cercheremmo di risolvere. È proprio la sete di certezze, questa errata percezione del sé che tanto confondono la mente creando sempre maggiore disagio; nel tentativo di salvare l’illusione della sicurezza, l’io si affanna tra i due estremi della pienezza e del vuoto, sperando che l’una o l’altro gli forniscano la protezione necessaria.
Per tutti “è estremamente difficile sostenere un senso di assenza senza trasformare quell’assenza in una presenza di qualche sorta”, scrive lo psicoanalista A. Phillips. Nella visione buddista, un essere realizzato ha compreso la propria mancanza di un vero sé, e non si tratta di una condizione psicotica, anche se potrebbe sembrare. L’esperienza del vero sé che tanto preoccupa l’occidente è possibile, nella forma più diretta, grazie al riconoscimento della “vacuità” del sé, ovvero della sua insostanzialità.
Questo avviene grazie alla consapevolezza delle numerose manifestazioni del sé, grazie alla capacità di diventare consapevoli delle immagini del sé senza crearne di nuove. Tutto ciò è molto difficile in quanto è presente il tentativo di ricreare o di riconquistare quel sentimento originario di perfezione infantile da cui siamo stati tutti inesorabilmente separati; pretendiamo solidità basandoci sul quel senso dell’io di cui un tempo abbiamo fatto esperienza sul seno materno. La psicoterapia buddista lentamente porta alla scoperta delle illusioni inconsce che coltiviamo sul sé, i desideri fondamentali, e metterli a nudo, dissipando l’ignoranza e scoprendo la natura immaginaria del sé.
Fin qui sembrerebbe che l’esperienza della consapevolezza porti gradualmente ad uno stato di sgretolamento dell’identità simile a quello vissuto nelle psicosi. Non è così perché lo sviluppo della capacità di essere presente momento per momento alla natura della mente, tipica della meditazione e dell’addestramento mentale buddista, permette di fare esperienza del sé senza distorsioni dell’idealizzazione o della fantasia illusoria. Anziché incoraggiare un sé consolidato la concezione buddista vede una capacità di integrare in maniera flessibile le esperienze potenzialmente destabilizzanti di in sostanzialità e di impermanenza.
Di fondamentale importanza è aiutare la persona a trovare un modo per restare con le proprie angoscie senza affrettarsi a soffocarle….non permettere la fuga dalle emozioni ma creare un contenitore adatto ad accogliere e a far sperimentare l’emozione. L’esperienza della vacuità del sé non richiede l’annullamento delle emozioni ma solo che si impari a farne esperienza in maniera diversa. Le persone sono talmente abituate e preoccupate di abbandonare i propri sentimenti negativi che non ne sperimentano mai l’insostanzialità. Il buddismo insegna un nuovo modo di stare con i propri sentimenti, grazie alla sospensione del giudizio pur continuando a mantenere il contatto con gli oggetti dell’esperienza, in questo caso con le emozioni negative.
La psicoterapia bubbhista prende come punto di partenza la mente quotidiana, una mente non educata, e mira allo sviluppo di un particolare atteggiamento; la consapevolezza di ciò che realmente avviene a noi e in noi…non cercando di cambiare qualcosa, ma osservando la mente, le emozioni, il corpo.
Questo tipo di attenzione non giudicante è di per se terapeutica….se si riescono a scindere le reazioni personali dai semplici eventi in sé. Anziché fuggire le emozioni penose o aggrapparsi a quelle piacevoli, si impara a contenere qualsiasi reazione facendole spazio e non identificandovisi completamente. Solo rimanendo con le emozioni distruttive possiamo vederle, viverle e accettarle veramente…possiamo rimanere in compagnia dello spiacevole. In Occidente la grande intuizione di Freud fu quella che era possibile sospendere, nel setting terapeutico, quella che chiamava la “facoltà critica”….per prestare attenzione a tutto ciò che emergeva.
Non dovremmo, dunque, eludere lo spiacevole ma accettarlo…accettare qualunque cosa emerge e entrare, come diceva Winnicott, in “uno stato in cui non vi è da reagire il sé può cominciare a esistere”.
Lentamente, rimanendo in compagnia di un dolore dal quale di solito ci si ritrae è possibile arrivare a una trasformazione tale da sentire come lo spiacevole non và per forza rifiutato. Si parla di un atteggiamento di maggiore apertura nei confronti dei conflitti interni, una maggiore capacità di accoglienza, di un maggiore spazio psicofisico tale da ospitare diverse emozioni; rimanere con tali esperienze percependone la transitorietà, l’impermanenza.
Per non cadere in malintesi o fraintendimenti non si finirà di ripetere che tali esperienze richiedono un “io” , in senso psicoanalitico, capace di contenere e di integrare vissuti che di solito producono una destabilizzazione violenta.
Degli aspetti psicoterapeutici più precisi e di tecniche si parlerà nella seconda parte dell’articolo.
Altri Saggi e Articoli
La percezione
La percezione è il processo mediante il quale traiamo informazioni sul mondo nel quale viviamo. [...]
La personalità
Non esiste una concezione universalmente condivisa di cosa sia la personalità, tuttavia si può affermare [...]
Lo Sviluppo Affettivo
Un sano sviluppo della personalità dipende sia dall'adeguato sviluppo della sfera cognitiva, affettiva e sociale, [...]
Lo Sviluppo Cognitivo
Per sviluppo cognitivo si intende lo sviluppo delle attività intellettive. Molti autori, tra i quali [...]
Lo Sviluppo Morale
Gli studi e le ricerche sullo sviluppo morale, che comprendono sia il giudizio morale sia [...]
Lo Sviluppo Sociale
Il processo di socializzazione inizia fin dalla primissima infanzia, dopo la nascita, e progredisce durante [...]
Vygotskij
Vygotskij costruì una visione storico-culturale della psicologia evolutiva dando rilevanza alle attività mentali più alte, [...]
Cosa è un emozione
Le emozioni sono reazioni soggettive mosse da una logica di adattamento o di regolazione nei [...]
La psicologia di C.G. Jung e l’Alchimia
Nelle sue bellissime memorie (Aniela Jaffè, Ricordi, sogni, riflessioni di C. G. Jung, ed.BUR) Jung [...]
Trance Cultura – Viaggio in Mongolia
Ipnosi Trance e Cultura: Mongolia, Diario di un viaggio “Niente è vero, o vero può [...]