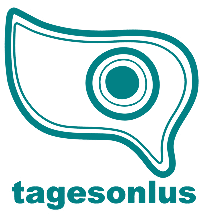Ma che cos’è un simbolo?
E, tanto per essere scettici, siamo sicuri di voler dare tanto valore ad un elemento così apparentemente astratto nel processo di sviluppo e mantenimento di un contesto clinico e psicopatologico del genere di cui sopra?
Ebbene, rispondendo ancora secondo una visione dinamica della psiche, dobbiamo considerare innanzitutto che nel mondo psichico il simbolo, per dirla con Carl Gustav Jung, rappresenta un’espressione che rende nel miglior modo possibile un dato di fatto complesso e non ancora afferrato chiaramente dalla coscienza .
Quindi ciò che dal mondo inconscio trasale e comunica nel suo stesso esistere e manifestarsi, prende una forma simbolica ogni qualvolta il mondo conscio non sia in grado di accogliere con continuità e comprendere integralmente il messaggio. In breve, ogni qualvolta il messaggio venga letto come un messaggio, ossia discriminato nel fluire degli eventi come oggetto diverso, “scisso”, o “altro” da sé, e non in quanto parte di un’intima e olistica dinamica di scambi.
Questo vale sia in ambito individuale, relativamente a simboli soggettivi, sia in ambito culturale, relativamente a simboli collettivi.
Detto in altri termini, stiamo parlando di un problema di scissione-separazione, un problema di integrità.
In un ottica di sviluppo e “realizzazione del Sé”, nel senso più ampio che possiamo dargli, il simbolo rappresenta comunque una sorta di possibilità “ambivalente”, progressiva e regressiva al tempo stesso: da un lato un’anticamera all’intima comprensione e metabolizzazione di contenuti importanti su se stessi e/o sulla realtà (del resto due facce della stessa medaglia), risultato “sintetico” di un gioco di forze conflittuali, “unificatore di coppie di opposti”, anzitutto conscio e inconscio e di seguito tutte le altre qualità antitetiche ad essi collegati. Dall’altro una sorta di schermo rispetto ad una conoscenza diretta del mondo, un velo che ci allontana dal reale o integro senso delle cose, da una diretta connessione con la fluidità, quiddità e semplicità degli eventi, (psichici e non, se proprio vogliamo distinguerli); in breve, una rappresentazione, potremmo dire “illusoria”, o “immaginifica”, che per quanto adattativa ha in sé il potere di alienarci, separarci e scinderci dalla realtà, dalla sua vividezza e immediatezza, proprio a specchio di quanto siamo alienati, separati e scissi “da” e “in” noi stessi.
In quest’ottica il simbolo può essere inteso alla stessa stregua del “farmacòn” del mondo greco, divenendo a seconda dei casi e del punto di vista sia il male che la cura, sia veleno che sostanza con proprietà curative (antidoto).
In ogni caso è sempre lo stesso Jung a sottolineare più volte nelle sue opere quanto l’uomo sia sempre più drasticamente scisso nella sua integrità originaria, vivendo in una costante e sempre più estrema disarmonia tra conscio e inconscio, in una sempre più netta separazione e conflittualità interna ed esterna.
La nostra stessa società comune diviene sempre più differenziata e discriminante, sempre più sterilmente analitica e razionale, “chiedendo” a sua volta sempre maggiori scissioni e atteggiamenti dialettizzanti, compromesso essenziale perché la psiche individuale possa continuare ad esserne parte.
Ma questa appartenenza viene pagata cara.
In altri termini l’Io individuale è sempre più rigido, fragile e frammentato, a rischio nella sua integrità verso il disturbo conclamato (di cui il disturbo borderline rappresenta solo un esempio estremo).
Allo stesso tempo, paradossalmente, nonostante oggi ci si trovi nel pieno del processo di globalizzazione-omologazione, è come se stesse venendo, gradualmente ma inesorabilmente, a mancare una reale capacità di sintesi, di ritorno all’uno a partire da conflitti tra opposti, quindi una reale capacità di simbolizzare; quest’ultima, infatti, anche in contesti di normalità, diviene sempre più “disturbata”, perdendo le sue caratteristiche di adeguata funzionalità adattiva e lasciando inevitabilmente il campo ad un’espansione sempre maggiore del disagio della personalità.
Il disturbo “borderline” di personalità è il disturbo dei nostri tempi, un disturbo in forte espansione, ed è bene sottolineare che l’unica differenza tra normalità e patologia in questo contesto specifico è di natura quantitativa e non qualitativa.
E’ come se questa continua discriminazione e differenziazione razionale porti ad una continua “lisi” del simbolico, liberando così l’energia psichica in esso di volta in volta investita e contenuta, come in una sorta di rottura di legami chimici.
Quest’energia, poi, in quantitativi sempre maggiori, inevitabilmente si ricompatta nei nuovi sotto-prodotti simbolici di quelle stesse lisi, acquisendo in essi sempre più potere e consistenza. Come dire, tanto più violentemente e sconsideratamente tale potere “significante” verrà rimosso-scisso nella sua forma simbolica iniziale tanto più irruento sarà il suo ritorno, parallelamente ad una perdita costante di consapevolezza di sé e assorbimento nel nuovo simbolo.
Scindere-rimuovere il simbolo senza realmente integrarlo a livello cosciente significa comunque scindere e rimuovere, e quindi perdere e rinunciare a, un’importante parte di sé.
Su queste basi il simbolo potrà arrivare eventualmente e gradualmente ad incarnare un potere “magnetico” o attrattivo talmente grande da intrappolare l’individuo o la collettività (a seconda dei casi) in un’identificazione sempre più stretta e rigida direttamente proporzionale alla fragilità dell’Io, fino a portare ad esempio a fenomeni di fanatismo, individuale o collettivo, dei più svariati, oppure fino ad accecare e possedere l’individuo in precisi disegni simbolici-archetipici, espressi in una sorta di agìta schiavitù inconsapevole.
Queste lisi del simbolico nascono in qualche modo come tendenza a smantellare la dimensione “misterica”, “significante” e quindi anche ansiogena del simbolo, tuttavia lo smantellamento non può che essere illusorio.
Come la più comune delle leggi psichiche, il potere che si voleva scongiurare non potrà che tornare più forte in un’altra forma, inaspettata, fino all’agìto, espressione del più forte potere simbolico-archetipico.
Lo smantellamento sistematico e su larga scala della dimensione simbolica come fenomeno culturale non può che portare alla sofferenza psichica individuale ed ad un sempre maggiore disagio della civiltà.
Infatti, il simbolo, individuale o collettivo che sia, nel suo ruolo protettivo dell’integrità dell’Io, viene al giorno d’oggi sempre più deformato, indebolito, re-inventato utilitaristicamente, oppure smantellato “selvaggiamente” , svelato ed esorcizzato dal suo potere difensivo e “significante”.
E’ come se la “magia” ed il “mistero” della dimensione simbolica, appunto “significante”, stiano gradualmente perdendo valore nell’ambito razionalistico che sempre più ci rappresenta, avendo appunto sempre meno terreno su cui attecchire ed essendo quindi sempre più relegati nella dimensione inconscia del rimosso.
Ad esempio nelle società primitive fino ad arrivare al medioevo compreso, si educava al simbolo, al rituale e al rispetto di disegni simbolico-archetipici di cui l’uomo si riteneva parte al pari di ogni cosa.
E non per questo non si insegnava a relativizzare. Tuttavia lo si faceva senza rinunciare al rispetto, conservando la magia, e senza smantellare cinicamente, o “uccidere”, il simbolo stesso nel suo valore “didattico” (lo dimostrano i numerosi studi etnologici relativi alle società cosiddette “primitive” esistenti anche ai giorni nostri). Come se esistesse una sorta di serena consapevolezza del fatto che, al momento giusto, senza sforzi e del tutto spontaneamente il simbolo si sarebbe sciolto da solo, come evaporando in una presa di coscienza più alta, prima che razionale soprattutto emotiva.
Dall’illuminismo in poi, invece, fino ad arrivare ai giorni nostri, si è vista la nostra società comune (ormai suo malgrado) educare sempre più radicalmente e freneticamente alla discriminazione e alla rigida scissione razionale, alla sterile spiegazione riduttiva, al cinismo nichilista, al materialismo più sfrenato, allo smantellamento selvaggio dell’universo simbolico ormai senza più valore: in breve a simboli sempre più “malati”.
Questo fino ad arrivare ad una vera e propria rottura con le proprie radici culturali, negazione-rinnegamento di un mondo simbolico importantissimo e frattura psichica altamente destabilizzante.
D’altro canto il simbolo svolge fondamentalmente una sorta di funzione mediatrice, ammortizzante e sintetica, tra psiche conscia e psiche inconscia, contenendo l’attrito e quindi l’ansia che un simile incontro-scontro può spesso generare. Detto più semplicemente una funzione di sostegno e integrativa dell’Io.
Il simbolo è l’istanza mediatrice dell’incompatibilità tra coscienza e inconscio, mediatore tra ciò che è nascosto e ciò che è manifesto, e non è né astratto né concreto, né razionale né irrazionale, né bene né male (se non dipendentemente dal soggetto), né reale né irreale: è sempre entrambi.
La proprietà di mediazione e congiunzione del simbolo rappresenta l’unico contrappeso realmente naturale e risanatore in grado di affrontare con successo il pericolo della dissociabilità essenziale della psiche e l’inerente e costante minaccia per la sua unità strutturale. Il simbolo riunisce in se gli opposti, li supera per poi, dopo l’unione lasciarli di nuovo scindere onde evitare che si produca rigidità e stasi. Esso mantiene la vita psichica in continuo flusso. E questa capacità della psiche di generare e sintetizzare coppie di opposti nel simbolo è chiamata da Jung “funzione trascendente”, nel senso di transizione da un atteggiamento psichico ad un altro.
In ogni modo il termine “simbolo” trova diversi riferimenti significativi in varie lingue: ad esempio il tedesco “sinnbild”, composto da “sinn” (senso, significato), come componente integrante della coscienza conoscitiva e formativa, e “bild” (immagine), come contenuto, materia prima del grembo primordiale creativo dell’inconscio collettivo che assume significato e forma proprio dall’unione con la prima componente.
Ora, la compresenza dei due fattori linguistici rappresenta la polivalenza delle possibilità ermeneutiche e la densità di significati legati al simbolico.
D’altro canto, nel termine in questione risulta facile notare una congiunzione di elementi maschili (forma-senso) ed elementi femminili (materia prima-immagine) che costituiscono una sorta di “coincidentia oppositorum” alchemica, una “coniucto”, o “matrimonio” che non sia per questo fusione in unità inscindibile, irrigidita e cristallizzata. Come scrive Jolande Jacobi, allieva di Jung ed eminente studiosa del suo pensiero:
“Un dissidio in questo ‘matrimonio’ porta amare conseguenze proprio come nella vita di ogni giorno. Nella stessa misura in cui uno dei partner acquista superiorità e l’altro è assoggettato, il simbolo diventa in maniera preponderante il prodotto di una sola delle parti e quindi anche più un sintomo che un simbolo, ‘sintomo cioè di un’antitesi repressa’. E nel caso di una totale disunione può essere sintomatico di una corrispondente dissociazione tra conscio e inconscio. A questo punto si può dire: il simbolo è morto (estinto). Le due ‘metà’ del matrimonio si sono separate in inimicizia e si sono ritirate ognuna nel proprio campo specifico. Alla materia prima di immagini, al contenuto dell’inconscio viene a mancare la forza formativa della coscienza, e quest’ultima si inaridisce perché non è più irrorata dalla sorgente alimentatrice dell’immagine. Tradotto nella realtà psicologica di un individuo, ciò significa che o niente dell’inesprimibile, del misterioso e del presciente delle profondità inconsce vibra più nel simbolo, in modo che il suo ‘senso’ può essere completamente conosciuto e compreso diventando così un semplice ‘segno’; oppure che, tagliato via dalla coscienza e dal suo potere di attribuire significato, il simbolo degenera in un sintomo psicotico. Un simbolo è quindi vivo solo finché è ‘pregno di significato’, ossia soltanto finché gli opposti, ‘forma’ e ‘materia prima d’immagini’ (tesi e antitesi), sono riuniti in esso in una totalità (sintesi) e il suo rapporto con l’inconscio rimane attivo e dotato di senso.”
In ogni modo, etimologicamente parlando, il termine “simbolo” trova origine nella lingua greca: “symbàllein”, ad esempio, era un verbo usato nel significato di “unire” e composto da “syn”, “sin” (insieme) e “bàllein” (mettere, gettare). “Symbolon” invece era usato nel senso di “tessera” o “segno di riconoscimento”.
Infatti, spiega Jung, il termine “symbolon” indicava la “tessera hospitalitatis”, ossia la moneta spezzata le cui due metà combaciavano perfettamente e di cui, secondo un’antica usanza, due amici, al momento di separarsi, prendevano con sé una parte ciascuno.
Questa gesto esprimeva la separazione di due parti un tempo unite, o similmente l’unione di due parti temporaneamente separate; l’angoscia di una separazione esorcizzata dal codice di un gioco, ma allo stesso tempo anche la possibilità di ricongiungersi in un unico linguaggio-immagine.
Il simbolo è la formazione reattiva alla perdita, o meglio, l’angoscia della perdita sublimata.
Esso diviene ciò che ci dis-identifica dall’oggetto o evento concreto per identificarci con l’oggetto ideale, interiore e soggettivato. Ecco perché ci libera e incatena allo stesso tempo.
Il simbolo diviene quindi il frutto dell’incontro tra due realtà che si sfiorano come in una faglia; un frutto che trans-duce, nel suo valore “mercuriale”, la polivalenza polimorfa della realtà inconscia, con tutto il suo potere frantumante, in una più rassicurante “imago” che tenti di dare un senso più limitato e mediato alla realtà anche in termini di realtà conscia.
Esso è la sintesi della tensione tra opposti che a loro volta richiedono una compensazione nell’unità.
Per dirla ancora con Jung il simbolo rappresenta da un lato una sorta di “condensatore” dell’energia psichica, e dall’altro, allo stesso tempo, un’“analogia della libido”, ossia un trans-duttore di energia: una rappresentazione idonea ad esprimere la libido in modo equivalente e trasporla-“spostarla” in forma diversa dall’originale. Si sta parlando di una sorta di punto medio, di contatto e scambio, tra due ordini di linguaggi, l’uno contaminato dell’altro.
In altre parole, il linguaggio inconscio si manifesta attraverso certe forme, è vero, ma è la coscienza discriminante col suo proprio “paio di occhiali” che ordina quelle manifestazioni proprio in quel linguaggio, leggendole proprio in quelle forme. Ma dove ha origine la funzionalità di questo processo?
Dal punto di vista affettivo e libidico la semiosi risulta essere strettamente legata alla figura materna, figura primaria d’attaccamento. Per dirla con Lacan la madre è simbolizzata nel gioco significante della sua presenza-assenza, pertanto assume statuto di madre simbolica. Ad un certo punto, però, il bambino scopre che la madre non risponde, non obbedisce sistematicamente al suo richiamo non essendo necessariamente in sincronia con le sue esigenze o bisogni. Ed è a questo punto che la madre comincia ad incarnare la potenza e la dirompenza del reale. Di conseguenza il bambino non può che modificare, indirettamente, la sua idea di reale.
Dal momento che la madre, detentrice degli oggetti reali che offre al bambino per soddisfare i suoi bisogni naturali, non risponde più con regolarità, essa diviene reale, in quanto resiste al simbolico (per Lacan è reale ciò che non si assoggetta al simbolico). Per contro proprio l’oggetto reale diverrà simbolico, ossia “transizionale” rispetto alla figura materna. In sintesi si verifica un chiasmo in cui la madre da simbolica diventa reale (in virtù della sua assenza) e l’oggetto da reale diventa simbolico (in virtù della sua presenza sostituente), laddove per oggetto simbolico si intende un oggetto il cui valore non dipende dalle sue qualità intrinseche ma dal fatto stesso di essere un dono della madre onnipotente (che può esserci o non esserci, dare o non dare), un segno del suo stesso amore.
In ambito di relazioni oggettuali, l’oggetto buono si incarnerà nella madre presente, l’oggetto cattivo con la madre assente. In altri termini, originariamente la madre adeguata viene recepita come “specchio mentale responsivo”, come illusione fusionale e non come ambiente esterno ed estraneo.
In seguito, proprio nel contenere l’angoscia di perdita e di separazione generata dall’assenza di tale figura (“perdita dell’oggetto”) o da naturali desideri di esplorazione, attraverso l’identificazione proiettiva e la proiezione, l’infante arriva a più stadi a creare proto-simboli nel tentativo di ricostruire fantasticamente l’unità con la madre.
Se fino ad ora aveva vissuto in un’identità di percezione tra simboleggiato e simboleggiante, adesso non può più farlo e tenta con equazioni simboliche di ripristinare tale identità.
In particolare per la personalità borderline, il meccanismo di difesa maggiormente utilizzato resterà l’identificazione proiettiva: com’è noto la proiezione avrà il fine di eliminare costantemente le immagini aggressive del Sé, ma anche la conseguenza di sviluppare oggetti persecutori da cui il paziente dovrà difendersi. D’altro canto, l’intensità dei bisogni proiettivi nel processo di maturazione psichica e individuazione finirà per indebolire i confini dell’Io in alcune aree, creando una mancata differenziazione tra parti del Sé e dell’oggetto.
In ogni modo è dalla separazione psico-affettiva originaria che comincia a svilupparsi l’angoscia, il principale stato affettivo che accompagna la genesi dell’Io, tanto che si potrebbe addirittura postulare che tra i due esista una sorta di coincidenza. Come dire che l’Io è perdita-angoscia “sublimata”.
Proprio dall’angoscia e nell’angoscia, infatti, comincia a prendere forma, in un processo di maturazione psichica ed affettiva di natura prevalentemente difensiva, una prima differenziazione individuale così come una prima funzionalità simbolica completa. Ha inizio la formazione dell’Io. Ha inizio la distinzione dall’altro.
Del resto il simbolo, quale creazione e funzione dell’Io, si forma attraverso la disillusione e l’apprendimento depressivo dell’interezza dell’oggetto e della sua ambivalenza, che a sua volta si trasforma in ambivalenza affettiva connessa a tale oggetto.
L’angoscia di separazione e perdita e la rabbia per la caduta delle pretese di onnipotenza comportano il riconoscimento dell’oggetto come “altro da sé” e la concezione dell’oggetto assente.
A questo punto la conseguente elaborazione dei vissuti di lutto porta ad un prevalere del processo di introiezione rispetto alla proiezione, con la conseguente formazione di un “oggetto interno”.
Il sostegno e il potere integrante del simbolo, con tutto il suo valore affettivo-“transizionale”, divengono ora effettivi.
Tuttavia, in un evidenza clinica sempre più frequente ai nostri giorni, può succedere che non si crei una sufficiente differenziazione all’interno della relazione Io-oggetto, permanendo così un’indistinzione tra oggetto simboleggiato e simbolo (in realtà pseudo-simbolo per il suo carattere “privato” e incomunicante).
Tale indifferenziazione porta proprio ad un disturbo, una difficoltà, o addirittura un’incapacità nella simbolizzazione, tipica dei casi limite e caratteristica alla base anche del “pensiero concreto” psicotico.
In virtù di tutto questo possiamo affermare che una disfunzione relazionale precoce diviene l’origine dell’impossibilità di un’adeguata evoluzione nel processo di simbolizzazione; processo in grado di portare ad un’integrazione del significato soggettivo con quello oggettivo.
Inoltre l’incapacità delle figure parentali a funzionare come “contenitore” (ossia in grado di accogliere, elaborare e trasformare le identificazioni proiettive idealizzanti o persecutorie) preclude al figlio l’accesso al loro reticolo simbolico-affettivo, nonché l’inserimento nelle catene associative consensuali attraverso una immediata risonanza e riverberazione empatiche.
Ed è ovvio quanto una rete di simboli condivisi possa strutturare, sostenere e contenere l’Io in quanto simbolo transizionale, contribuendo alla sua difesa e assicurazione contro le angosce fusionali e di indistinzione.
Come si dice, il simile chiama (e si sostiene con) il simile, o meglio “Similia similibus curantur”, ossia è proprio un efficace collegamento alla rete simbolica condivisa a garantire la stabilità dell’Io individuale: una rete simbolica che diviene un sostegno fatto appunto di ulteriori appigli-simboli, specchi simbolici rassicuranti dalla caduta nel vuoto del non essere.
Ma cosa si intende esattamente per disfunzioni relazionali precoci?
Si pensi ad esempio a quei contesti familiari e affettivi in cui la madre, figura d’attaccamento primaria, non tolleri la differenziazione del bambino, mantenendolo così in uno stato di dipendenza; oppure, anche contemporaneamente, a quelle situazioni in cui un genitore tenda a non rispettare i tempi di crescita del bambino forzandolo a precorrerli.
Tutto questo contrasta nettamente con un’autentica maturazione dell’individuo che prende origine plausibilmente dal mancato superamento della fase di separazione e individuazione, ipoteticamente situata intorno ai due anni di vita, dipendentemente dalla figura materna.
In questa fase specifica, l’arresto dello sviluppo psico-affettivo sembra essere legato ad una tipica forma di comunicazione a “doppio legame” in cui la madre da un lato spinge il bambino ad allontanarsi da sé ma dall’altro lo punisce affettivamente ogniqualvolta lo faccia.
Si sta parlando di una sorta di educazione all’ambiguità e all’ambivalenza psico-affettiva in grado di generare nel bambino quello che molti hanno chiamato tecnicamente “sdoppiamento delle imago”, o “scissione della realtà” o “dell’oggetto” in “buono” o “cattivo”, del resto manifestazione tipica degli stati limite. Una scissione utile proprio alla lotta contro l’angoscia di perdita dell’oggetto amato e contro il rischio di arrivare ad una modalità psicotica difensiva di “sdoppiamento dell’Io” con angosce di frammentazione e morte, scissione che può precludere ad una esplosione psicotica di vera e propria “frammentazione dell’Io”.
Per dirla con Kenberg negli stati limite risulta caratteristica l’incapacità di realizzare una sintesi tra le introiezioni e le identificazioni positive legate alle pulsioni libidiche e le introiezioni e le identificazioni negative legate alle pulsioni aggressive, per cui stati contradditori dell’Io sono attivi in modo alternante. Questa scissione esercita un effetto dannoso sui processi integrativi che dovrebbero stabilizzare l’Io in una forma unitaria: si è di fronte quindi ad una “sindrome dell’identificazione diffusa” in cui proprio il deficit delle capacità integrative impedirebbe di sperimentare un’autentica depressione.
In ogni caso, a causa di questa educazione all’ambivalenza, il processo di separazione e individuazione rischia di non giungere a compimento arrivando letteralmente allo stallo: nel soggetto cominciano a cristallizzarsi l’intolleranza alla separazione e alla perdita con l’aggiunta di persistenti fantasie di fusione. Egli si sentirà “gratificato della dipendenza” da oggetti o persone, cercando costantemente di ricreare con gli altri quella relazione genitore-bambino in cui poter sia controllare sia essere controllati, sia perseguitare sia essere perseguitati, sia possedere sia essere posseduti.
In lui l’ambiguità della dipendenza-onnipotenza verso l’oggetto sostitutivo del rapporto simbiotico con la madre prima, e con l’oggetto transizionale poi diverrà una caratteristica modalità di azione/reazione al mondo. Tanto più che tale ambiguo dominare l’oggetto o la persona rappresentativi dell’oggetto transizionale riesce ad esercitare in lui un azione catartica e calmante.
Secondo alcune teorizzazioni è proprio la presenza di un oggetto transizionale, passato o presente, il carattere discriminante e fondamentale per distinguere il disturbo borderline dagli altri disturbi di personalità.
Tuttavia nel borderline l’oggetto transizionale non ha svolto bene la sua funzione di mediatore tra realtà interna e realtà esterna nella fase di separazione dalla madre e di conseguenza il nucleo dell’identità personale non si è potuto formare normalmente. Ora, risulta chiaro che parlando di oggetto transizionale stiamo parlando ancora di un simbolo.
Ma se l’oggetto transizionale è un risultato del processo di differenziazione ed individuazione rispetto all’unità simbiotica madre-bambino, e quindi uno stadio del processo di formazione dell’Io, possiamo affermare che l’Io stesso è una sorta di elemento transizionale, ossia un simbolo (cristallizzato e autonomizzato), o perlomeno un qualcosa che condivide con esso le radici ed i processi formativi. In un certo senso l’Io è il simbolo creatore di simboli, o meglio il simbolo “luogo” di simbolizzazione, spazio simbolico di creazione di quegli stessi simboli che vanno a costituirlo detenendo la sua esistenza; esso è istanza ordinante dei processi mentali, sintesi tra due ordini di linguaggi reciprocamente contaminati, punto medio e mediatore tra domande; punto medio tra conscio e inconscio, unità e molteplicità; tecnicamente, una formazione di compromesso tra pressioni dell’Es e del mondo esterno, con capacità analitiche e sintetiche al tempo stesso.
Ma l’Io è anche per definizione una sorta di imago di identificazione alienante dall’unità fusionale. Un risultato della scissione originaria che trova il suo gemello speculare nell’“altro”, anch’esso risultato simbolico, immagine di introiezione e proiezione. Si sta parlando di una spaccatura che generando la diade Io-altro è separazione e soprattutto perdita della totalità.
Infatti, come accennato in precedenza, l’Io è strettamente legato all’angoscia di separazione, ne è la sede, o meglio potremmo dire che in qualche modo è quella stessa angoscia “sublimata”, con un adeguato processo trasformativo-difensivo, in identità soggettiva che lenisca quella stessa angoscia di perdita.
Ora, nell’ambito dei casi limite, in virtù della loro difficoltà di integrazione dell’Io e quindi di simbolizzazione, si avrà a che fare con un’angoscia non sufficientemente identificata, o diffusamente identificata, un angoscia soprattutto “agìta”, ma non per questo meno intensa e problematica.
Stiamo parlando comunque di un’angoscia “narcisistica” che spacca, divide e differenzia ulteriormente il mondo a partire dalla separazione originaria (ferita narcisistica primaria), come un’innata istanza protettiva che nella difesa da forze interne ed esterne, ossia proprio dai prodotti di quella scissione, si differenzia sempre più divenendo un elemento altamente autonomo, indipendente, articolato e funzionale all’adattamento.
Secondo le parole di Servadio l’individuo, per vivere, deve distinguere dentro e fuori di sé. Però rimane in lui l’attrazione regressiva verso l’indistinto, quell’attrazione pericolosa che Freud aveva descritto nelle prime pagine del “Disagio delle civiltà” come “sentimento oceanico”, per cui si vorrebbe, contro le forze che spingono all’obiettivazione, far tutt’uno col mondo e con le cose.
Proprio l’angoscia sarebbe il prezzo di questa rinuncia.
E proprio l’angoscia diverrà col tempo una reale funzione dell’Io, un segnale di dispiacere che permetta di mobilitare al bisogno tutte le energie disponibili al fine di lottare contro le pressioni pulsionali rimosse.
In ogni modo, in base all’autonomizzazione di cui sopra, gradualmente, non potrà che generarsi un’identità al prezzo di una distinzione dall’altro (certamente anch’esso simbolico), con la strutturazione sempre più netta di un Io “linguistico-discriminante”.
Nell’ambito di contesti relazionali disturbati questo stesso Io diviene portatore oltre che di semplici caratteristiche di personalità anche di una predisposizione ad una o più forme sintomatiche, in genere, proprio in quanto tali, scisse dall’integrità del soggetto.
Ed ecco che anche il sintomo si mostra nella sua potenziale natura simbolica-patologica delle dinamiche psichiche (in base alla sua capacità di veicolare messaggi e trasmettere significati), nonché nel suo valore transizionale e contenitivo dell’angoscia, ennesima rifrazione dall’unità originaria.
Tuttavia l’Io non ha il sintomo, non lo possiede, ma è il sintomo nel momento in cui esso si manifesta, quindi potremmo dire che in qualche modo ne è posseduto.
Si pensi, ad esempio, alle fobie, alle malattie psicosomatiche o alle perversioni: tutti esempi che evidenziano quanto la manifestazione sintomatica sia rappresentata nel simbolo, come nel caso dell’oggetto fobico, oppure sia essa stessa un simbolo come nelle somatizzazioni di conflitti o nelle perversioni.
Questo non contraddice tuttavia l’evidenza, sia per le malattie psicosomatiche che per le perversioni, di una difficoltà, un disturbo o addirittura un’incapacità nei processi di simbolizzazione, in comune come sappiamo col disturbo borderline di personalità.
E’ come se una funzione simbolizzante disturbata o pressoché assente corrisponda, in un linguaggio più strettamente junghiano, all’essere posseduti dal simbolo o addirittura da ingranaggi simbolici, ossia da un sistema di simboli reciprocamente interagenti (archetipo). Come se l’essere invischiati nel simbolo, addirittura fusi con esso, o incastonati in un preciso disegno simbolico-archetipico non ci permetta il distacco necessario alla simbolizzazione stessa, intesa come sintesi stabilizzante nell’instabilità tra stati (instabilità conflittuale conscio-inconscio) e come facoltà mentalizzante, nonché l’eventuale presa di coscienza trasformativa (“change”).
Potremmo dire che essere catturato nel simbolo releghi nell’inconscio e allontani dalle possibilità di consapevolezza, e questo vale, seppur in modi diversi, sia per la dimensione psichica della “norma” sia ancor più per quella “deviante”, disturbata o patologica (se proprio le si vuol distinguere).
Ma prendiamo ancora l’esempio delle fobie: in esse l’oggetto-simbolo fobico sembrerebbe assorbire la quasi totalità dell’attenzione e dell’energia psichica dell’individuo, ed il mancato soffermarsi o preoccuparsi riguardo all’evitamento di tali oggetti nella realtà quotidiana genera ansie e angosce incontrollate, intollerabili ed ingestibili per il soggetto.
E’ come se le ansie e le angosce di cui sopra, catturando e imbrigliando tali energie vitali in investimenti nel loro contenimento, tolgano le stesse energie e risorse alla possibilità di prendere reale coscienza del problema, di divenire emotivamente consapevoli delle intime dinamiche psichiche che si nascondono dietro la fobia stessa; come se esse distolgano dalla possibilità di uscire dai confini imprigionanti dell’ordinaria identità fobica per guardarli per così dire “nell’insight”, “dall’esterno”, e quindi (ri)scoprirli terapeuticamente in un conseguente “change”.
Tuttavia non possiamo omettere il fatto che l’oggetto-simbolo fobico, per quanto drammatico possa essere, alleggerisca comunque l’Io cosciente dal peso di una problematica conflittuale ben più grave, assolvendo ad una sorta di funzione adattiva-contenitiva di ansie e angosce ben peggiori di quelle fobiche.
Il simbolo, quindi, anche nella sua angosciosa terribilità mantiene un valore calmante e sedante per il fatto stesso di essere frutto di uno “spostamento”.
Similmente, i rituali ossessivi-compulsivi, vere e proprie rappresentazioni simboliche-archetipiche ove ogni atto, gesto, movimento o parola assume un fortissimo connotato simbolico, da un lato hanno il potere di invischiare, risucchiare ed inghiottire l’individuo in trame che lo legano e lo intrappolano, il più delle volte inconsapevolmente, in giochi di ruoli coercizzanti. Dall’altro rappresentano comunque una dimensione rassicurante, stabilizzante ed ordinante, avendo anch’essi il potere di contenere ed esorcizzare l’ansia e l’angoscia-Io alla base dei rituali stessi.
Ora, se è vero che nella migliore delle ipotesi, nella maturazione della psiche infantile, la madre diviene simbolo, o meglio funzione simbolizzante, è anche vero che il simbolo assurge a funzione materna, contenitiva e re-integrante davanti al rischio di una profonda e angosciosa frammentazione e dissoluzione.
Ma in particolare è la separazione dalla madre, quindi l’allontanamento dall’indistinzione originaria, affettiva e quindi “identitaria”, che di fatto genera le funzionalità simbolizzanti nell’individuo. E in quest’ottica probabilmente non è un caso che ogniqualvolta quest’ultimo si riavvicini ad una possibilità di indistinzione ed integrità tra conscio e inconscio verso quella significante unità originaria, ossia uno scambio fluido e senza mediazioni tra contenuti consci e inconsci in un contatto sufficientemente angoscioso, ne nasca una qualche forma simbolica che separa nuovamente, interponendovisi, ammortizzando e mediando così il diretto processo conoscitivo e di consapevolezza soggettivo.
A questo punto risulta più facile comprendere quanto nel disturbo borderline di personalità non sia casuale il parallelismo tra un disturbo della funzione simbolizzante ed un disturbo di ambivalenza nel processo di differenziazione e svincolo affettivo dalla figura materna.
Questa profonda difficoltà di simbolizzazione è espressa chiaramente dall’incredibile tendenza e facilità con cui i pazienti borderline ricorrono all’acting out, o passaggio all’atto, e a dinamiche “agìte” di aggressività, denotando una mancata capacità di mentalizzare, elaborare e quindi gestire i conflitti e le tensioni interne.
Secondo Jung il passaggio all’atto o l’agìto non mentalizzato può indicare chiaramente l’essere catturato in un disegno archetipico nonché l’inconsapevolezza di questo “stato di prigionia”.
La difficoltà a simbolizzare esiste laddove si viva “nel” simbolo, dal di dentro, intrappolati inconsapevolmente in esso senza possibilità di uscita.
Nel disturbo borderline di personalità in particolare il soggetto è preso “da” e “nel” simbolo talmente tanto da non poter simbolizzare; è identificato nella stessa ambivalenza del simbolo, posseduto da essa, tanto che arriva egli stesso ad incarnare e rappresentare l’ambivalenza tipica del disturbo in questione, passando senza mediazioni agli agìti problematici e all’acting out, altalenando tra umori e quindi “stati di coscienza” assai conflittuali senza soluzione di continuità.
E’ come se il simbolo o l’archetipo vivano e si nutrano in qualche modo della nostra energia vitale e consapevolezza; come un velo che ci separa dalla realtà inghiottendoci, un disegno simbolico capace di muoverci come burattini nelle sue dinamiche, negandoci alla realtà materiale (“Wirchlichkeit”) per consegnarci alla sola realtà psichica (“Realität”).
Per Jung questa dinamica resta comunque vera, anche se in modi e misure diverse, a seconda che si parli di un contesto di normalità o psicopatologico.
In ogni modo, alla luce di tutto questo si potrebbe affermare che sì, uno dei problemi del disturbo borderline di personalità è senza dubbio l’estrema (rispetto alla norma) difficoltà a simbolizzare ma che d’altro canto, più a monte, il problema nasce dall’impossibilità di liberarsi dall’archetipo da cui si è “posseduti”, dall’impossibilità di osservare da un punto di vista “altro”, o distaccato, i propri confini e conflitti, se non altro “agìti”: questo sarebbe già un buon inizio nell’ottica di una (ri)scoperta identitaria ed una sua evoluzione terapeutica.
Ma cosa si intende realmente quando si parla di “identità”? E assodata la problematica identitaria nell’ambito degli “stati limite”, cosa ha a che fare quest’ultima con la dimensione ipnotica che qui ci si propone di esaminare?
Altri Saggi e Articoli
Sviluppare amnesia alla fine di una trance
Suggestione Post ipnotica e Seguire attraverso Separatamente dalle interruzioni improvvise e la frantumazione del rehearsal [...]
Ipermnesia ipnotica
L’ipermnesia ipnotica è un fenomeno che implica ricordi ed immagini vivide e simili a fotografie. Questo [...]
Ipermnesia: Studi sperimentali
La maggior parte delle ricerche sull’ipermnesia sono riassunte in esauriente revisione della letteratura condotta da [...]
Ipermnesia: Indicazione d’uso
Una delle indicazioni primarie per l’uso dell’ipermnesia in psicoterapia è quello di cancellare l’uso controproducente [...]
Elicitare un fenomeno di ipermnesia
Si pensa che le suggestioni di ipermnesia devono essere date in una maniera estremamente permissiva [...]
Esempi naturalistici di rimembranze
Un altro metodo per elicere itare l’ipermnesia implica il raccontare storie riguardante la vita di [...]
Regressione d’età
L’uso della Regressione d'età viene usata per aiutare il cliente ad andare indietro, con modalità [...]
Elicitare un fenomeno di regressione d’età
Gli iniziali sforzi di Erickson per elicitare un fenomeno di regressione d'età erano basati primariamente [...]
Memorie confabulative nella regressione d’età
E’ ormai cosa nota quanto la regressione d’età porti all’esperienza certa di un “vero ricordo” [...]
Apprendimento
Definiamo apprendimento l'insieme dei processi che, provocando una modificazione dei vecchi modelli di comportamento o [...]